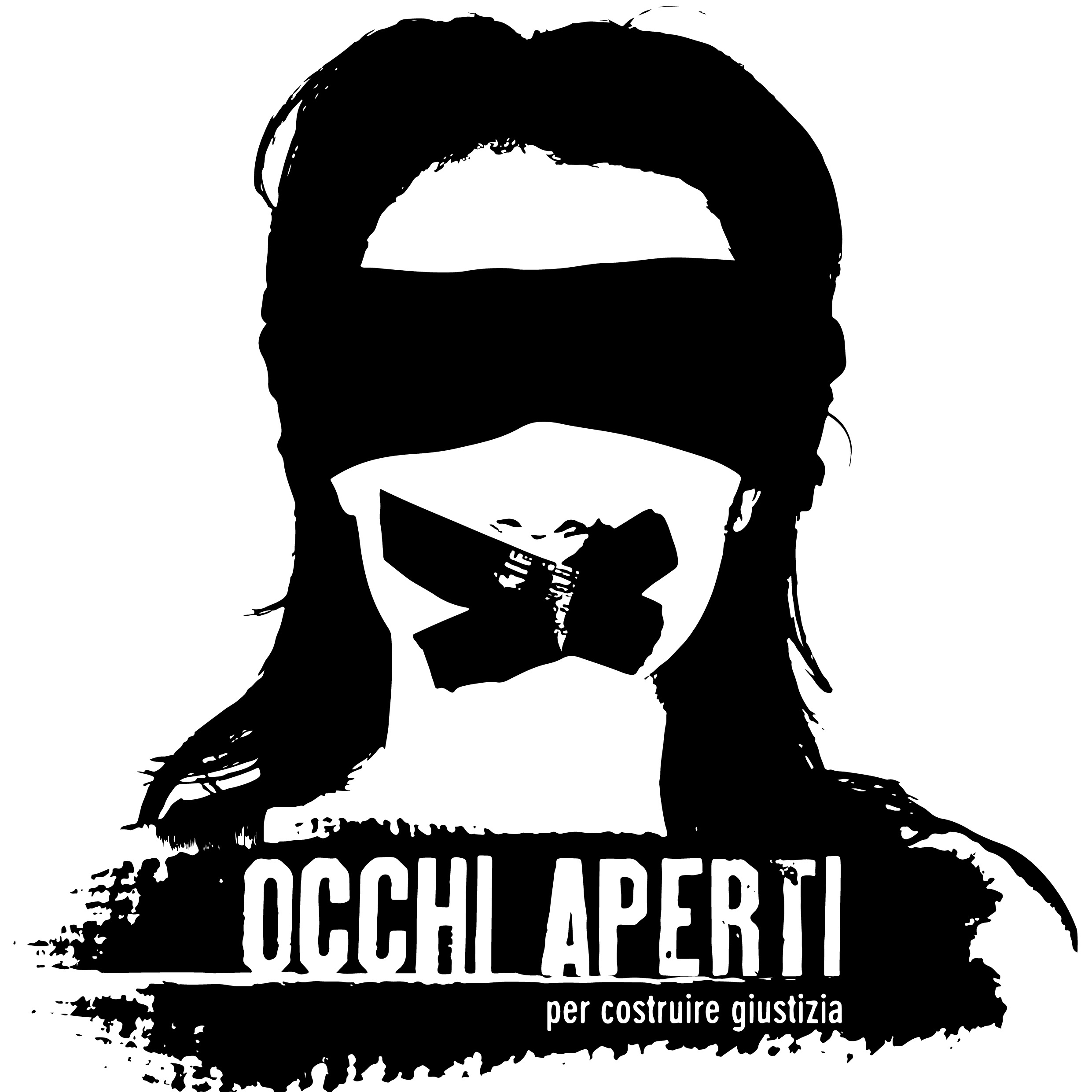Wökrã è una montagna sacra. Wökrã, nella lingua Macro-Je, indica il luogo di origine del popolo Krahô. Il luogo da cui il popolo Krahô della grande nazione Mehĩ è stato scacciato con l’arrivo dell’uomo bianco. Gli indios Krahô, originari del […]

Wökrã è una montagna sacra. Wökrã, nella lingua Macro-Je, indica il luogo di origine del popolo Krahô.
Il luogo da cui il popolo Krahô della grande nazione Mehĩ è stato scacciato con l’arrivo dell’uomo bianco.
Gli indios Krahô, originari del Maranhão, nella regione del Wökrã, furono deportati nel 1858 nel nord-est dello Stato del Tocantins nella riserva indigena denominata Krahôlandia. La riserva si trova nei comuni di Goiatins e di Itacajá tra i fiumi Manoel Alves Grande e Manoel Alves Pequeno, affluenti della riva destra del fiume Tocantins. All’interno ci sono 16 villaggi a forma di cerchio dove le case, costituite da piccole capanne, sono situate sulla circonferenza mentre al centro si trova l’area comunitaria dove vengono prese le decisioni più importanti della comunità. La vegetazione predominante è la savana, con presenza di foreste che accompagnano i corsi dei fiumi.
I tentativi di togliere terra e dignità, storia e vita agli indiani del continente americano sono esperienze tristemente conosciute dall’umanità. Ferite non rimarginate anche per gli stessi indios Krahô che, oltre alla deportazione e alle epidemie, nel 1940 hanno subito un grave massacro che li ha decimati. Con lo scopo di conquistare ed espropriare la terra, sono stati trucidati bambini, donne e anziani da parte dei proprietari terrieri confinanti.
Di tre grandi comunità ne rimase una.
Negli anni Settanta il popolo dei Krahô rischiò nuovamente l’estinzione a causa delle epidemie e a causa degli attacchi degli allevatori di bestiame che volevano impossessarsi della terra assegnata loro da governo.
Un decennio dopo, i leader dei villaggi krahô si resero conto che solo attraverso il recupero delle loro tradizioni, sarebbero riusciti ad evitare l’estinzione. Rischio purtroppo quanto mai attuale.
In questo momento assistiamo all’espropriazione economica favorita dalla grave povertà e fragilità di questo popolo. Il confronto con la società dominante Brasiliana, tecnologicamente e socialmente molto potente, li fa sentire sempre più inferiori e senza difese.
In questi ultimi anni è in corso una continua deforestazione, fuochi e una caccia indiscriminata da parte dei cacciatori di frodo (coloni bianchi confinanti e gruppi organizzati).
La conseguenza principale dei fuochi, della deforestazione e della caccia da parte del bianco è che i Krahô, che vivono soprattutto di caccia, pesca e piccole coltivazioni, incontrano sempre maggiori difficoltà nel procurarsi il cibo e la loro stessa sopravvivenza rischia di essere compromessa.
Inoltre i giovani sono sempre più attratti dall’apparente benessere della città dove però trovano solo violenza, alcolismo e prostituzione.
I GIOVANI
Per i giovani indios l’attrazione della città è potente: vita comoda, soldi facili e benessere. Illusioni che li spingono ad andarsene dal villaggio nella speranza di una vita meno difficile. Invece la realtà nelle grandi città li porta inevitabilmente verso lo sfruttamento e la miseria. Una dimensione molto diversa da quella a cui i giovani krahô sono abituati nel villaggio (molto povera ma protetta) e non hanno l’esperienza per poter affrontare quanto la città apparentemente “offre”.
Molti indios finiscono nel giro della prostituzione della droga e dell’alcolismo. Immagini purtroppo tristemente note per chi conosce la realtà del nord del Brasile. Molti giovani finiscono anche ad estrarre oro con mercurio o a portare sacchi di terra su fatiscenti scale per poi setacciarli per estrarne l’oro.
Lo sterminio dei popoli indigeni, avviato nei secoli delle conquiste, non si è ancora arrestato. Fondamentale per la sopravvivenza dei Krahô è che i giovani trovino le motivazioni per restare nel loro villaggio. E’ vitale che i giovani prendano coscienza del valore della propria cultura e si tutelino dalle attrazioni della società esterna che li ammalia prepotentemente. I giovani Krahô, cresciuti in villaggi dove le tradizioni indigene erano ancora praticate, dopo periodi passati nelle grandi metropoli brasiliane, hanno fatto ritorno nella riserva, fondando nuovi villaggi con una nuova consapevolezza. Ma se da giovani non avessero avuto modo di conoscere la loro cultura e i rituali che scandiscono il ritmo della vita del popolo (rischio concreto che i bambini krahô odierni stanno vivendo), non avrebbero avuto motivo per ritornare.
La cultura e i riti
Basilare per la cultura Krahô sono i riti. Il tempo nel Kri, che significa comunità e non villaggio (aldeia) come il bianco lo definisce, è scandito da rituali volti alla vita comunitaria e alla necessità di mantenere attiva la vita sociale per fare fronte di tutto ciò che circonda il villaggio e che diventa minaccia per il sistema comunità. Anticamente a minacciarli potevano essere tribù rivali o la paura della foresta che li circondava. Oggi è il mondo del bianco. Per capire la forza aggregante dei riti basti pensare che l’unico motivo di espulsione dal Kri è l’adulterio. Non è semplice descrivere i meccanismi socio culturali che nei millenni ha sviluppato questa società, ma la definizione di cultura pura è decisamente appropriata per questo popolo in via di estinzione.
Ogni sera gli uomini si incontrano nel centro del Kri, nel Kä che rappresenta il sole, Pyt. Dal kä partono stradine a raggiera chiamate pry-karã. I pry-karã sono i suoi raggi e collegano il centro con il cammino circolare esterno, detto kri-kapé. Il kri-kapé rappresenta la luna. E’ la sovrapposizione stilizzata della luna che ruota intorno al sole. Un linguaggio mitologico che non è solo memoria, ma cultura; non un semplice enunciato, ma tradizione sacra di un popolo.
Il kä è il centro sacro di tutta la vita sociale del popolo ed è il luogo sacro che richiama la forza di Pyt, il Signore dell’universo. In questo luogo vige la legge dell’unione e i problemi sono vissuti e dibattuti in funzione del bene comune. Le discordie e le conflittualità quotidiane vengono messe da parte, a meno che non si tratti di questioni di rilevanza particolare, nel qual caso l’anziano ne proporrà la discussione. Poi, in ogni gruppo familiare, prima che il sole tramonti deve esserci il perdono tra tutti i membri. Più che il perdono è più corretto parlare di dimenticare i torti subiti nella giornata.
Nei rituali, genericamente chiamati amji-kin, che tradotto letteralmente significa stato del volersi bene, questo perdono reciproco, questo dimenticare si estende a tutto il villaggio. Da qui la definizione di cultura pura.
Ogni amji-kin riprende un rituale specifico iniziato durante l’anno e scandito dalla stagione secca e dalle stagione delle piogge. Può essere il rituale dell’uomo lontra, del pesce, del creato o della raccolta della patata dolce, all’interno dei quali si inseriscono l’arrivo di ospiti nel villaggio, il raccolto, un voto propiziatorio, un dare il nome ad un bimbo, un matrimonio, l’iniziazione o altro.
Lo stato di amji-kin gioca un ruolo fondamentale per la convivenza pacifica dei gruppi familiari. Tutta la comunità in questa occasione dimentica problemi e litigi. E’ sorprendente perché avviene in maniera automatica, naturale. Non significa semplicemente: “ti perdono, ma stai attento a come ti comporterai”. Significa proprio dimenticare, metterci una pietra sopra, e per sempre. E’ normale che succeda questo. Durante l’amji-kin, che può durare da due a cinque giorni, i rapporti nel kri sono particolari: continue visite e scambi di doni tra famiglie, riunioni nel wyty, canti, danze meravigliose intorno al Kri e nel Ka durante la notte, corse e staffette. Il culmine del rito si raggiunge con il kwyr-kupu. Si tratta di un grande impasto di manioca cosparso di carne fresca. Viene preparato su uno tappeto di foglie di banana selvatica grande circa due metri quadrati e viene lasciato cuocere tutta la notte su pietre roventi. All’alba viene tagliato dai responsabili katämjê (rappresentante del gruppo della stagione secca) e wakmejé (rappresentante del gruppo della stagione delle piogge) e distribuito in parti uguali a tutti. Dopo il kwyr-kupu il clima di festa svanisce poco a poco ed il villaggio riprende gradatamente i ritmi quotidiani.
II rito funebre: il pär-kahäk
Il pär-kahäk è il rituale funebre che conclude il lutto per una persona cara, ma è anche un rito nostalgico, un rito dell’addio. I parenti più prossimi, durante tutto il periodo del lutto, che può durare anche un anno, non si pitturano, non si tagliano i capelli, non si tolgono ciglia e sopracciglia.
Questo amjkin dura una settimana intera ma il rituale conclusivo inizia nel pomeriggio del giorno designato, dura tutta la notte e termina al sorgere del sole. E’ un rito essenzialmente notturno. La notte è più adeguata al ricordo dei morti e si presta alla meditazione, alla paura, alle rappresentazioni. Il nascere del nuovo giorno invece è sempre un segnale di rinascita, di speranza e di vita.
I Krahô non hanno cimiteri quindi la persona defunta viene ricordata solamente fino al giorno del rito funebre. Da quel momento sarà dimenticata, come se non ci fosse più nessuna relazione, nemmeno nel ricordo, tra il mondo dei vivi e quello dei morti. I corpi dei defunti vengono interrati fuori del villaggio, ben discosti dalle case. I bambini sono tumulati più vicino perché i loro spiriti sono meno temuti. Per i Kraho esiste solo il paradiso e si ricorderà appena che in tal posto è avvenuta una sepoltura.
Accade raramente di ricordare una persona defunta dopo il rito funebre del pär-kähäk letteralmente tora falsa. Un tronco cavo ch rappresenta il defunto. Ciò avviene solo alla presenza di un anziano, di un capo dei riti o di un cantore, ed in maniera fuggevole. Non è dimenticata, ma il timore di richiamarne sulla terra lo spirito ricordandola, non lascia indugiare nel ricordo.
Con questo rito viene sciolto il legame con il passato. Ciò che è morto è morto, ciò che è vivo è quello che conta.
La necessità di continuare a celebrare i riti è fondamentale per il popolo Kraho.
Ma ad ogni rito, che può durare anche una settimana e che coinvolge tutto il Kri, è necessario avere cibo. Ogni famiglia coinvolta nel rito, per esempio per l’iniziazione della figlia, deve procurare cibo per l’intero Kri. Non è facile procurare carne di caccia dato le scorribande dei cacciatori bianchi nella riserva. Riso è manioca sono più facili da procurare ma non sufficienti per soddisfare il kri e il rituale. La carne è fondamentale per celebrare l’Amjkin.
E’ una responsabilità importante prendersi cura di questo popolo. Una responsabilità umile e saggia di preservazione della vita di uomini della foresta protettori della biodiversità e di una cultura ancestrale patrimonio di una umanità inconsapevole di tali ricchezze.